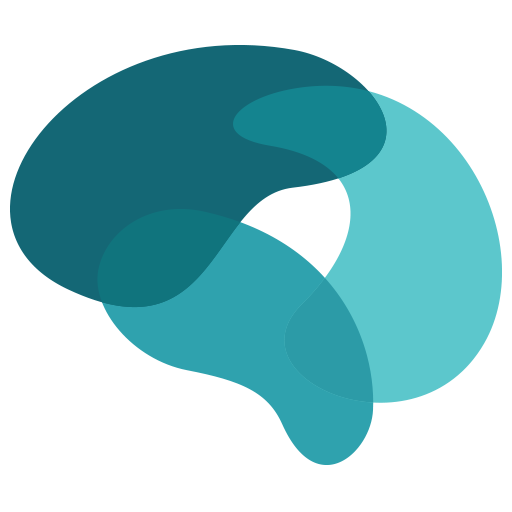Cos’è la metacognizione?
Può essere definita come la propensione generale del soggetto a riflettere sulla natura della propria attività cognitiva e a riconoscere la possibilità di utilizzarla ed estenderla.
(Cornoldi, 1995)
La metacognizione è un’abilità che si basa sulla consapevolezza dei propri processi cognitivi e del loro funzionamento, include le attività esecutive che presiedono al monitoraggio e all’autoregolazione dei processi cognitivi.
Questo costrutto è costituito essenzialmente da tre aspetti principali:
- Atteggiamento metacognitivo
Con questo concetto ci si riferisce alla capacità di riflettere sul proprio funzionamento mentale e sullo sviluppo di alcune idee che sono alla base del funzionamento mentale: ovvero il fatto che esso si possa analizzare, controllare e modificare.
Un esempio di atteggiamento metacognitivo riguarda la convinzione che esistano strategie più appropriate rispetto ad altre per affrontare un determinato compito.
- Conoscenze metacognitive specifiche
Queste riguardano le informazioni e le idee che un individuo ha acquisito rispetto al funzionamento mentale e ai fattori che sono potenzialmente in grado di influire su di esso.
Riprendendo l’esempio precedente, in questo caso le conoscenze metacognitive specifiche si traducono nella consapevolezza che esistono determinate strategie adatte a un determinato caso.
- Processi metacognitivi di controllo
Riguardano le operazioni attraverso le quali l’individuo dirige l’esecuzione dei propri processi cognitivi, ciò è strettamente influenzato dall’atteggiamento metacognitivo e si lega anche alle conoscenze metacognitive specifiche.
In questo caso ci si riferisce, ad esempio, alla capacità di comprendere il compito e valutarne difficoltà e importanza, saper stimare le proprie abilità e risorse, definirsi gli obiettivi (ad esempio in relazione alle caratteristiche personali e specifiche di una prova). Inoltre, questi processi riguardano anche il saper esaminare le strategie che possono essere utilizzate, decidere quali sono più funzionali, pianificare le fasi del compito da svolgere, monitorare l’attenzione e il rispetto del piano, valutare gli esiti della propria azione e trarne delle conseguenze.
Perchè è utile a scuola
Come abbiamo già parlato nell’articolo relativo alla costruzione del metodo di studio, la metacognizione rappresenta un aspetto fondamentale nell’apprendimento: diversi studi hanno dimostrato come una buona abilità metacognitiva si rifletta positivamente sulle capacità di apprendimento e sul rendimento scolastico (Cornoldi, De Beni e Gruppo MT, 1993; Cornoldi e Caponi, 1991).
Risulta infatti che vi sia una relazione causale e biunivoca tra metacognizione e prestazione, in quanto la prima influenza la seconda, ma a sua volta la prestazione e l’esperienza di apprendimento accrescono la capacità metacognitiva.
Di seguito definiamo dunque due esempi di guide pratiche in ottica metacognitiva, utili sia per gli studenti, durante lo studio, che per gli insegnanti, durante le lezioni in classe. Si tratta di una serie di punti che possono essere considerati per migliorare l’efficacia dello studio o della spiegazione.
Una guida metacognitiva per gli studenti
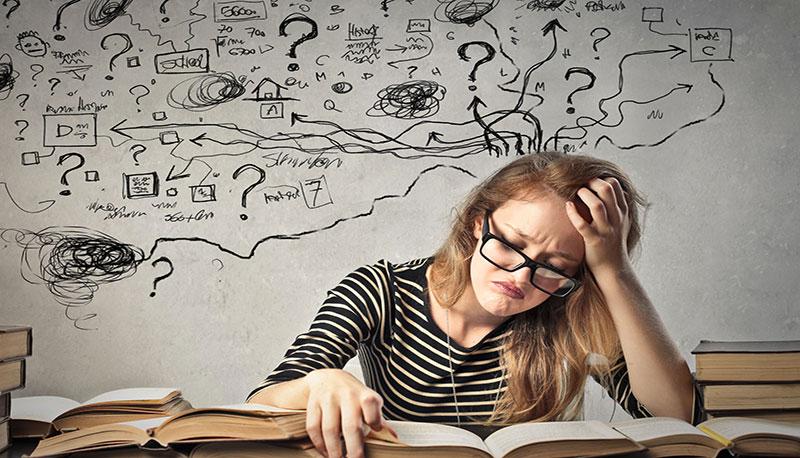
Cornoldi, De Beni e il Gruppo MT definiscono cinque aspetti metacognitivi che sono particolarmente importanti per lo studio e che sono tipicamente connessi all’uso di un buon metodo di studio:
- Concentrazione
È importante che lo studente sia in grado di riconoscere la sua capacità attentiva e sappia controllarla senza perdersi in altri pensieri.
- Selezione degli aspetti principali
Riguarda l’abilità di saper dirigere e soffermare l’attenzione in modo adeguato sui punti principali, imparando a selezionarli.
- Capacità di autovalutazione
Si tratta della propensione, da parte del ragazzo, a saper valutare in modo corretto le proprie capacità e le proprie prestazioni.
- Strategie di preparazione a una prova
Riguarda la capacità di comprendere in modo corretto un compito proposto, di stabilire i successivi obiettivi e adeguare di conseguenza i processi da mettere in atto.
- Sensibilità metacognitiva
Consiste nella tendenza a riflettere sul piano richiesto per svolgere determinati compiti e sulla capacità di predisporre piani adeguati.
Una guida metacognitiva per gli insegnanti
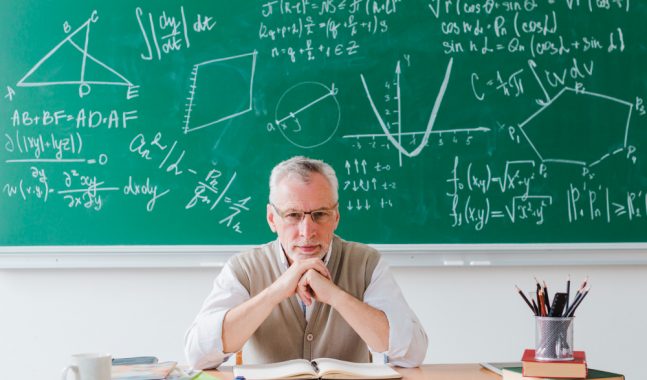
Anche qui, Cornoldi, De Beni e il Gruppo MT delineano un modello dedicato agli insegnanti (o educatori) per spiegare e far apprendere una determinata strategia in un’ottica metacognitiva. Vengono definiti sette passi fondamentali da mettere in atto nell’insegnamento, in modo da promuovere un atteggiamento metacognitivo:
- Definire in modo chiaro a cosa serve la strategia e come applicarla
È necessario che vengano definite in modo esplicito le fasi di una strategia, a ciò si deve poi aggiungere una spiegazione chiara del perché sia necessario usarla, cosa essa permette di fare, quando e dove può essere utile.
Per esempio, può essere utile la strategia della moltiplicazione come addizione ripetuta nei casi in cui lo stesso numero da sommare viene ripetuto più di 5-6 volte.
- Attivare le conoscenze pregresse
È importante tener conto del bagaglio di conoscenze che gli alunni hanno già acquisito, poiché alcune competenze potrebbero essere utili per apprendere la nuova strategia. Dunque si devono individuare e sollecitare questi aspetti per favorire l’apprendimento.
- Valutare il livello delle prestazioni attuali dei ragazzi
Si deve considerare a che punto si colloca la competenza dei ragazzi, fornendo loro un rimando su di essa e promuovendo i vantaggi dell’uso della nuova strategia.
- Fare la dimostrazione della strategia e delle autoistruzioni
Fondamentale è l’utilizzo del Modeling, attraverso il quale l’insegnante si pone come modello da imitare dimostrando l’uso della strategia in contesti significativi e utilizzando le opportune autoistruzioni attraverso un pensiero ad alta voce. Il dialogo interiore esplicitato potrebbe essere costituito da domande e affermazioni come: “Cosa devo per prima cosa?”, “Uso questa strategia perchè così posso comprendere meglio quello che leggo”, “Ho bisogno di fermarmi a riflettere”.
- Organizzare la pratica collaborativa
Per esercitare la strategia insegnata è opportuno prevedere occasioni di sperimentazione in piccoli gruppi o in coppia. Durante questi momenti devono essere monitorati i progressi e le difficoltà. Laddove vi sia necessità, è importante intervenire con una ulteriore spiegazione attraverso un insegnamento diretto o un insegnamento reciproco (tutoring).
- Esercitare la padronanza individuale
Una volta acquista la strategia, gli alunni devono esercitarsi in modo individuale attraverso la guida e i rinforzi dell’insegnante. L’intervento andrà piano piano a sfumarsi, fino a quando tutti i ragazzi non saranno in grado di applicare in modo corretto e pienamente autonomo quanto appreso.
- Promuovere la generalizzazione
Adoperare diversi materiali durante le esercitazioni permette di rendere più flessibile l’uso della strategia, favorendo il suo utilizzo in diversi contesti. Inoltre questo obiettivo può essere incentivato anche attraverso discussioni, in piccoli o grandi gruppi, sull’opportunità di utilizzare o meno le strategie imparate a seconda delle situazioni che si presentano.
Allenamento metacognitivo
È possibile sviluppare o migliorare la propria competenza metacognitiva attraverso interventi mirati che vanno a sollecitare tutti gli aspetti ad essa connessi. La promozione di questa abilità è fondamentale per un buon andamento scolastico ed è particolarmente utile per tutti quei casi di diagnosi di DSA o ADHD, dove i bambini tendono ad essere molto impulsivi, poco strategici e poco attenti al procedimento da attuare per la soluzione di un qualsiasi problema.
Bibliografia:
- Cornoldi C., De Beni R. & Gruppo MT (2015). Imparare a studiare – strategie, stili cognitivi, metacognizione e atteggiamenti nello studio. Trento: Erickson.Cornoldi C.,
- Ricerca e Sviluppo Erickson (2015). BES a scuola – i 7 punti chiave per una didattica inclusiva. Trento: Erickson.